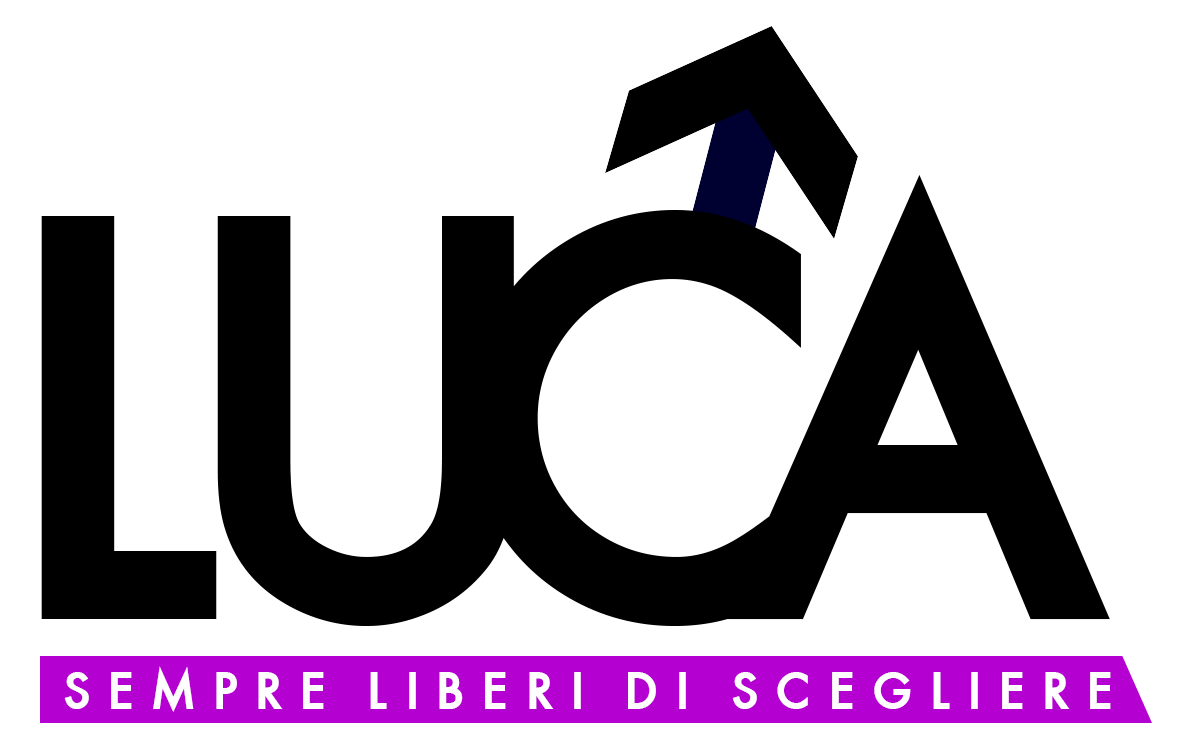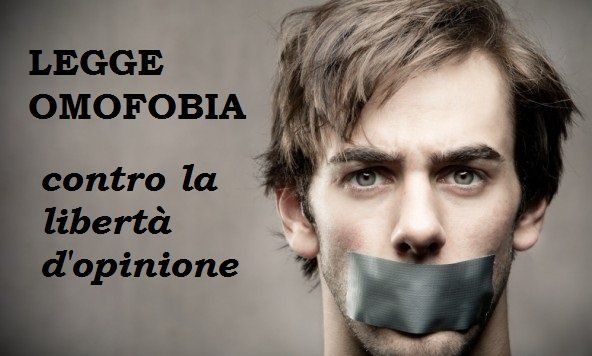OMOSESSUALI SI NASCE? Una Prospettiva Psicologica
“Gay si nasce” è uno slogan molto diffuso che suggerisce l’esistenza di una causa biologica e innata dell’omosessualità. Ma questa ipotesi è davvero supportata dalla scienza?
Nonostante l’interesse mediatico per teorie come il “gene gay”, il “cervello gay” o gli “ormoni gay”,
non esistono conferme scientifiche definitive che dimostrino l’origine innata dell’orientamento omosessuale. Al contrario, numerose ricerche hanno mostrato risultati inconcludenti o non replicabili. È in questo contesto che la psicologia offre una spiegazione alternativa, più articolata e personale.

Omosessualità: definizioni essenziali
L’omosessualità è definita come un’attrazione sessuale persistente e prevalente verso persone dello stesso sesso. Tuttavia, avere esperienze omosessuali o provare attrazioni occasionali non implica necessariamente un orientamento stabile.
È importante ricordare che l’orientamento sessuale non è un’identità fissa, ma una tendenza. Le sue origini sono multifattoriali: non esistono singole cause determinanti, ma un insieme di elementi che, in combinazione, possono contribuire allo sviluppo dell’attrazione omosessuale.
La prospettiva psicologica
Secondo la psicologia, l’omosessualità può essere interpretata come una risposta a ferite interiori, legate in particolare allo sviluppo dell’identità sessuale e al bisogno di affetto non soddisfatto. Si tratta spesso di dinamiche relazionali familiari e sociali, che impediscono una piena maturazione identitaria.
Omosessualità maschile
Relazioni familiari
Il ruolo del padre è fondamentale nello sviluppo dell’identità maschile. Se il padre è distante, ostile o emotivamente assente, il figlio può vivere una profonda frustrazione affettiva. Una madre dominante o invischiante può complicare ulteriormente questo processo, ostacolando la naturale identificazione del bambino con il genitore dello stesso sesso.
Il distacco difensivo
Quando il bisogno di affetto paterno viene sistematicamente frustrato, il bambino può attivare un meccanismo inconscio di autoprotezione chiamato distacco difensivo. Questo porta a reprimere il desiderio di amore paterno, ma allo stesso tempo può generare ostilità verso la figura paterna e, per estensione, verso il mondo maschile.
Rapporti con i coetanei
Il ragazzo che non si è identificato con la figura paterna può sentirsi diverso dagli altri maschi, sviluppando un senso di inferiorità e inadeguatezza. L’ammirazione verso i coetanei può trasformarsi, nel tempo, in attrazione erotica: un tentativo inconscio di colmare il vuoto identitario.
Aspetti fisici e autostima
Carenze fisiche, come gracilità, malformazioni genitali (es. ipospadia) o bassa statura, possono rafforzare il senso di vergogna e inadeguatezza, soprattutto in contesti relazionali già fragili. Non sono cause dirette, ma fattori aggravanti.
Abusi sessuali
L’abuso sessuale, in età infantile o adolescenziale, può compromettere profondamente l’identità e la percezione di sé, generando bassa autostima, relazioni disfunzionali e una possibile attrazione omosessuale come risposta a queste ferite.
L’origine dell’eros
Nel maschio omosessuale, l’attrazione sessuale è spesso il tentativo inconscio di ricevere l’amore paterno mancato e di appropriarsi della virilità che sente di non possedere. L’erotismo diventa un modo per ottenere ciò che emotivamente è stato negato.
Omosessualità femminile
Relazioni familiari
Per la bambina, il riferimento primario è la madre. Una madre fredda, assente o invischiante può impedire una sana identificazione con la femminilità. Anche il padre ha un ruolo decisivo: quando non riconosce la femminilità della figlia o la coinvolge in modo egoistico, può contribuire a minare la sua identità.
Distacco difensivo
Anche la figlia, nel tentativo di difendersi dalla sofferenza relazionale, può reprimere il bisogno di amore materno. In questo modo, si indebolisce la sua identificazione femminile, dando spazio a una ricerca affettiva sostitutiva.
Rapporti con le coetanee
La mancanza di appartenenza al mondo femminile e l’assenza di figure femminili di riferimento possono indurre nella ragazza un senso di estraneità. Le relazioni omosessuali, in questo contesto, diventano il tentativo di ricevere affetto materno e di costruire un’identità.
Abusi sessuali
L’esperienza traumatica di abusi può indurre nella donna una sfiducia generalizzata verso gli uomini, favorendo la ricerca di sicurezza in relazioni con altre donne. Anche qui si tratta di un fattore predisponente, non deterministico.
Il desiderio affettivo
Nella donna, l’attrazione omosessuale ha spesso una componente più affettiva che sessuale. Si cerca nella partner una figura materna surrogata: qualcuno che si prenda cura di lei, la rassicuri, la faccia sentire amata. Ciò può portare a forme di dipendenza emotiva.
L’influenza culturale
La cultura contemporanea, con la sua apertura verso ogni forma di sperimentazione sessuale, può influenzare profondamente i giovani. In un contesto in cui tutto è fluido, il confine tra affetto, ammirazione e attrazione può diventare confuso. Ciò può spingere alcuni a identificarsi come omosessuali sulla base di esperienze temporanee o pressioni esterne.
Conclusione
La prospettiva psicologica non pretende di fornire risposte semplici, ma invita a considerare il vissuto profondo delle persone, le loro ferite, i bisogni non soddisfatti e i percorsi di ricerca interiore. Affermare che l’omosessualità abbia spesso radici psicologiche non significa colpevolizzare nessuno, ma restituire dignità e complessità al cammino umano.
Negare o censurare queste dinamiche per motivi ideologici non aiuta nessuno. Comprendere, ascoltare e accompagnare resta il primo passo verso qualsiasi autentico percorso di crescita personale.
Di seguito, trovate l'intervista completa a @psico_attualitaa che ringraziamo per la collaborazione ed il contributo.
OMOSESSUALI SI NASCE?
OMOSEX 2.0
SPECIFICARE: non è che il genitore non voglia bene e non si parla di eventi occasionali di astio e attrito col figlio, ma di una relazione improntata sulla freddezza, distanza, ostilità.
Spesso nel mondo omosessuale si sente ripetere “gay si nasce”, slogan che presume un’origine biologica e innata dell’omosessualità e quindi naturale e accettabile tanto quanto l’eterosessualità. Ma le cose stanno veramente così?
Scopriamolo!
Sebbene a livello mediatico l’ipotesi delle cause biologiche (gene gay, cervello gay ed ormoni gay) sia ancora in voga, in realtà non è mai stata confermata. Infatti questa ipotesi non solo non è mai stata supportata dalla ricerca, ma addirittura è stato dimostrato il contrario!
Quindi omosessuale non si nasce.
Ma allora cosa sta alla base dell’omosessualità?
La psicologia viene in aiuto.
Infatti l’ipotesi psicologica è stata da sempre confermata da studi rigorosi e non è mai stata confutata. Naturalmente a partire dagli anni ’80 essa ha subito una vera e propria censura per motivi ideologici e politici, fino ad essere spesso trascurata nel campo della ricerca.
Ma cosa dice la psicologia in merito?
Prima di rispondere ecco alcuni chiarimenti.
Cosa si intende per omosessualità?
L’omosessualità è un’attrazione sessuale persistente e prevalente per le persone dello stesso sesso, mentre provare un’attrazione sessuale occasionale o avere rapporti sessuali occasionali con persone dello stesso sesso non significa avere un orientamento omosessuale. Inoltre è bene chiarire che l’omosessualità è un’inclinazione, un orientamento, una tendenza e come qualsiasi altra tendenza non costituisce un’identità.
È bene anche ricordare che si tratta di un insieme di fattori che contribuiscono all’insorgere dell’omosessualità, i quali, se presi da soli, non necessariamente predicono un orientamento omosessuale. Infine quando si delineano le radici dell’omosessualità è sempre bene tenere a mente che non si tratta di regole esatte e rigide, ma di linee guida generali che vanno sempre adattate alla storia unica ed irripetibile della persona.
IPOTESI PSICOLOGICA
L’ipotesi psicologica afferma che alla base dell’omosessualità ci sia una ferita legata all’identità maschile o femminile della persona, nello specifico l’omosessualità non è altro che un tentativo di risanare questa ferita.
Da cosa deriva questa ferita interiore? Entrano in gioco dinamiche complesse legate alle relazioni familiari, al rapporto con i coetanei, alla percezione di sé e talvolta all’abuso sessuale.
Queste dinamiche impediscono alla persona di sviluppare un’identità sessuale matura, ben definita e sicura. Naturalmente esistono delle differenze tra l’origine dell’omosessualità maschile e femminile e adesso inizieremo da quella maschile.
OMOSESSUALITA’ MASCHILE
Partiamo dall’infanzia. Ogni bambino ha bisogno di essere accettato, riconosciuto, amato ed ammirato dai genitori, soprattutto da parte del genitore dello stesso sesso.
Quindi le relazioni familiari hanno un’importante influenza sulla creazione del “sé maschile” o identità maschile, in particolare il padre ha un ruolo fondamentale nella vita del figlio, perché funge da modello di uomo da imitare. Inizialmente il figlio maschio si identifica con la madre, ma a partire dai primi anni di vita (1 anno e mezzo-3) il bambino si identifica col padre, genitore che funge da esempio di mascolinità e su cui il figlio plasma la sua identità maschile.
Però può accadere che il processo di identificazione col padre non avvenga, poiché questo ha instaurato un rapporto freddo, distaccato o ostile nei confronti del figlio e, così facendo, non ha saputo soddisfare il bisogno di affetto del figlio.
In tutto questo entra in gioco persino la madre, perché anche lei può ostacolare il processo di identificazione del bambino col padre.
Come?
Instaurando un rapporto troppo stretto col figlio, risultando dominante, invadente, apprensiva o addirittura castrante.
Questa dinamica può avvenire anche con altre figure femminili dominanti, come una nonna, una sorella maggiore, ecc.
In questo modo la fisiologica identificazione col padre viene meno ed il figlio si identifica con la madre, assumendo così tratti psicologici tipicamente femminili.
Inoltre la mancata identificazione col padre comporta anche la mancata identificazione col mondo maschile in generale.
Gli effetti deleteri possono essere mitigati se il bambino ha un’altra figura maschile da cui ricevere amore e con la quale identificarsi, ad esempio un nonno, uno zio, un fratello maggiore, un insegnate, ecc.
DISTACCO DIFENSIVO
Ma cosa accade di preciso nella psiche del figlio?
Come accennato all’inizio, il figlio desidera essere amato dal padre e quando ciò non accade si crea una ferita interiore profonda.
Infatti l’assenza o l’ostilità persistente del padre provocano una profonda ferita affettiva nel figlio.
Il bambino si trova quindi in una situazione di stallo: da una parte sente il bisogno di affetto e vicinanza del padre, ma dall’altra ha paura di essere di nuovo rifiutato o disprezzato e quindi di soffrire ancora.
L’unica via d’uscita è il “distacco difensivo”, un meccanismo di difesa inconscio per cui il figlio non ricerca più l’affetto e la vicinanza del padre, fino a reprimere il bisogno di amore paterno.
In questo modo il bambino si protegge dal dolore dell’ennesimo rifiuto o disprezzo che riceverebbe dal padre.
Tra l’altro, il distacco difensivo fa insorgere un sentimento di rabbia e ostilità nei confronti del padre, che non sa soddisfare il bisogno di amore del figlio.
In seguito il figlio generalizzerà questo atteggiamento con tutti i maschi, compresi i coetanei e, così facendo, perderà la possibilità di avere altre figure maschili con cui identificarsi.
Comunque è bene precisare che non sempre si parla di negligenze o maltrattamenti da parte dei genitori, ma di una relazione col padre che provocava frustrazione e sofferenza (perché il figlio sente che il genitore non soddisfa il suo bisogno di essere amato), al punto che il figlio non cerca più di soddisfare la sete di amore del padre e questo comporta l’allontanamento del figlio dal genitore, tanto da non comunicare più con lui o di farlo con difficoltà.
È bene anche precisare che non si tratta necessariamente di un padre che effettivamente non ama il figlio, ma anche di quei casi in cui il genitore vuole bene al figlio, tuttavia non riesce a trasmettere il suo affetto in modo efficace.
RAPPORTO COETANEI
Anche il rapporto coi coetanei può essere determinante nello sviluppo dell’omosessualità maschile.
Infatti quanto descritto sopra può gettare le basi per una predisposizione all’omosessualità e talvolta la goccia che fa traboccare il vaso può essere il rapporto coi pari.
Rispetto ai coetanei, che invece hanno avuto un processo normale di identificazione, il bambino o ragazzino che ha vissuto quanto sopra descritto si sente diverso dagli altri ragazzi e tagliato fuori dal mondo maschile, come se non vi appartenesse.
Ma per quale motivo si sente alienato?
Perché, a differenza dei suoi coetanei, non ha avuto nessuno che lo aiutasse a sviluppare la sua virilità e la sua identità maschile.
Naturalmente il ragazzino nota queste differenze e comincia a fare paragoni con gli altri ragazzi.
Il risultato?
Frustrazione.
Il ragazzino vorrebbe essere come gli altri maschi, vorrebbe essere anche lui un vero uomo, ma non ci riesce ed entra in un circolo vizioso di autocommiserazione che lo porta ad un forte senso di inferiorità rispetto ai coetanei.
Quindi il ragazzino con tendenze omosessuali si sente meno uomo rispetto ai coetanei.
Qui troviamo il nocciolo dell’omosessualità maschile: un forte senso di inferiorità e di inadeguatezza.
PROBLEMI FISICI
In una condizione del genere, tutto ciò che può esasperare il senso di inferiorità può contribuire a far insorgere o rafforzare l’omosessualità, come ad esempio le carenze fisiche.
Le carenze o “menomazioni” fisiche possono far diminuire l’autostima maschile, ad esempio troviamo la bassa statura, una costituzione particolarmente gracile, tendenza al sovrappeso, problemi di organi di senso, labioschisi e, soprattutto, l’ipospadia, una malformazione congenita del p*ne per cui il meato urinario non è posto sulla punta del glande, ma sul corpo del pene o addirittura in posizione scrotale o perineale.
Queste caratteristiche, soprattutto quelle legate alle parti intime, possono alimentare il senso di chiusura, di inadeguatezza, di vergogna, di essere diversi rispetto agli altri maschi, elementi che sono alla base dell’omosessualità maschile.
Queste caratteristiche fisiche di per sé non provocano l’omosessualità, ma se sono accompagnate ad un contesto come quello descritto fin’ora, possono essere elementi che rafforzano il senso di inferiorità nel giovane e, quindi, l’attrazione omosessuale.
ABUSI SESSUALI
Come accennato all’inizio, anche l’abuso sessuale subito nell’infanzia può concorrere allo sviluppo del senso di inferiorità.
Infatti è risaputo che l’abuso sessuale negli adulti solitamente provochi bassa autostima e difficoltà nelle relazioni, oltre alla tendenza a ricercare relazioni abusanti e questo, insieme a quanto detto sopra, può formare il terreno fertile per l’orientamento omosessuale.
Questo fatto è stato dimostrato da diverse ricerche che hanno messo in luce come uomini con tendenze omosessuali abbiano subito abusi sessuali in misura significativamente maggiore rispetto agli uomini eterosessuali.
Naturalmente non significa che tutti gli uomini omosessuali abbiano subito abusi sessuali o che uomini che hanno subito abusi sessuali sviluppino poi attrazioni omosessuali, ma dipende dai fattori sopra descritti.
EROS
Ma come si arriva all’attrazione sessuale verso gli uomini?
Nonostante il distacco difensivo, il desiderio di ricevere l’amore paterno rimane.
Nonostante il senso di alienazione, il desiderio di essere un maschio vero rimane.
Cosa fare?
Ecco l’attrazione sessuale!
Col rapporto sessuale, infatti l’uomo riesce ad aggirare l’ostilità verso gli uomini e accedere così all’affetto maschile che gli è mancato nell’infanzia.
Al tempo stesso, tramite il rapporto sessuale, può fare sua la virilità dell’altro.
Non a caso spesso ciò che un uomo omosessuale trova attraente in un altro sono proprio quelle caratteristiche che per lui rappresentano la vera virilità e che vorrebbe avere.
Quindi l’attrazione omosessuale ha fondamentalmente due scopi: ricevere l’affetto paterno mancato nell’infanzia e costruire un’identità maschile che non si è sviluppata.
OMOSESSUALITA’ FEMMINILE
Per quanto riguarda l’omosessualità femminile troviamo dinamiche simili a quella maschile.
Infatti anche in questo caso le relazioni familiari sono determinanti per lo sviluppo dell’omosessualità.
Anche le bambine, come i maschietti, hanno bisogno di essere amate, accettate, accudite e stimate da parte dei genitori, soprattutto dal genitore dello stesso sesso, ovvero la madre.
Per la figlia non si ha come col maschio il cambio di identificazione dalla madre al padre, perché per la bambina il genitore con cui identificarsi è la mamma.
Infatti è proprio questa a fornire il modello di femminilità sul quale la figlia getterà le basi della propria femminilità.
Tuttavia anche in questo caso il normale processo di identificazione può non avvenire ed entrano in gioco entrambi i genitori.
Infatti può accadere che la madre non faccia sentire amata, desiderata, accudita e preziosa la figlia, instaurando un rapporto freddo o distante.
Così facendo la madre non soddisfa la sete di amore che la figlia ha nei suoi confronti.
Non è tutto.
Esiste un’altra dinamica per cui la figlia non si senta amata dalla mamma, ovvero il rapporto invischiato con la madre.
La madre, infatti, può instaurare un rapporto estremamente stretto con la figlia, tanto che la bambina si annulla per far star bene la mamma e, in casi estremi, è la figlia stessa che si prende cura di lei.
DISTACCO DIFENSIVO
Anche in questo caso, la figlia risponde col “distacco difensivo”: onde evitare di soffrire per il rifiuto e il disinteresse della madre o di sentirsi “schiacciata” da lei, la bambina reprime il suo bisogno di amore materno e, così facendo, viene meno il processo di identificazione con la mamma.
Tuttavia non è solo il rapporto con la madre a determinare l’insorgere dell’omosessualità femminile, perché è anche il genitore del sesso opposto a giocare un ruolo cruciale.
Il padre ha il ruolo di supportare e proteggere il rapporto che la figlia ha con la mamma e, al tempo stesso, di aiutare la bambina a differenziarsi dalla madre per aiutarla a scoprire la sua identità.
I padri possono abdicare a questo ruolo in modi diversi.
La figlia, quando non si sente amata dalla madre, cerca di sopperire a questa mancanza rivolgendosi al padre.
Tuttavia anche il padre può non soddisfare il bisogno della figlia e lo può fare o mostrarsi distante, freddo e disinteressato nei suoi confronti, oppure può essere eccessivamente coinvolto.
Il padre infatti può coinvolgere la figlia nelle sue attività e farla sentire connessa con lui, ma la coinvolge solo nelle cose che piacciono o che riguardano lui.
Ciò che piace alla figlia, i suoi desideri e la sua femminilità non sono contemplate.
Quindi la figlia nega gli aspetti più profondi e veri della propria identità per avere un briciolo di affetto e connessione almeno dal padre.
Altre volte il padre innesca meccanismi per cui spinge la figlia ad assumere caratteristiche maschili a discapito di quelle femminili, per cui la figlia è vista come l’”alter ego” del padre, come colei che riesce a coronare i sogni che il padre non è riuscito ad ottenere.
Anche in questo caso i desideri ed i bisogni della bambina sono ignorati.
Ancora può capitare che la figlia resti profondamente segnata dalla violenza del padre, tanto da assumere la convinzione inconscia che gli uomini sono pericolosi e che con loro non è al sicuro.
In questo caso, ciò che segna nel profondo la bambina non è tanto l’atto violento in sé, ma come la figlia vive quell’esperienza.
Per esempio una bambina può vivere con intenso terrore un’arrabbiatura del padre, il quale però non ha mai alzato le mani contro di lei o contro altri membri della famiglia.
In questo caso ciò che è stato traumatizzante per la piccola è stata la forte reazione di paura all’ira del padre, piuttosto dell’ira in sé.
Tutte queste dinamiche non aiutano la figlia a costruire un’identità vera e autentica, bensì la spingono a costruirne una fittizia e apparentemente forte.
Naturalmente gli elementi deleteri possono essere mitigati se la bambina avesse altre figure di riferimento femminili con cui identificarsi, come una zia, una nonna, una maestra, la mamma di un’amica, ecc.
RAPPORTO COI PARI
Anche in questo caso le ragazzine con tendenze omosessuali si sentiranno diverse e tagliate fuori dalle coetanee, che invece hanno avuto uno sviluppo identitario normale.
Per le adolescenti (e le donne in generale) avere l’amica del cuore è essenziale e le ragazze con attrazione omosessuale, a causa del senso di alienazione dalle coetanee, perdono questa occasione d’oro per poter costruire le basi della propria identità femminile.
ABUSI SESSUALI
Anche nell’omosessualità femminile, aver subito abusi sessuali, può contribuire allo sviluppo dell’attrazione omosessuale.
L’abuso infatti può far percepire l’uomo come pericoloso e quindi da starci alla larga.
Anche in questo caso, come nell’omosessualità maschile, le ricerche hanno messo in luce il fatto che la popolazione di donne omosessuali riporta un tasso più alto di abusi sessuali rispetto a quelle eterosessuali.
Naturalmente non tutte le donne omosessuali hanno subito abusi sessuali e non tutte le donne che hanno subito abusi sessuali hanno sviluppato l’orientamento omosessuale, infatti l’abuso sessuale di per sé non determina l’orientamento omosessuale, ma può favorirlo se si verificano anche le dinamiche sopra descritte.
EROS
La donna si ritrova quindi con una fame insaziabile di amore materno e per di più non ha la più pallida idea di chi sia.
Cosa fare?
Ecco che subentra l’attrazione sessuale verso le donne!
Anche in questo caso l’attrazione sessuale verso le persone dello stesso sesso assolve a due scopi: ricevere l’affetto materno e assumere una propria identità.
Quindi il fulcro dell’omosessualità femminile è la ricerca dell’affetto materno e della propria identità.
Infatti, a differenza degli uomini omosessuali, le donne omosessuali preferiscono la vicinanza emotiva e la cura, piuttosto del rapporto sessuale in sé.
Hanno bisogno di un surrogato della mamma che sia sempre disponibile a prendersi cura di loro e che le faccia sentire amate.
(Non a caso, tra le coppie eterosessuali, omosessuali maschili e femminili, quelle con la minore frequenza di rapporti sessuali sono proprio le coppie omosessuali femminili).
Inoltre, siccome queste donne spesso non hanno un’identità definita, tendono ad assumere l’identità della partner con cui stanno.
Questi bisogni infantili non soddisfatti possono sfociare molto spesso nella dipendenza affettiva, ovvero la donna ha bisogno della costante conferma dell’amore dell’altra per sentirsi sicura di essere amata.
Queste dinamiche ricordano molto il rapporto simbiotico che si riscontra tra madre e figlia neonata, dove la figlia è completamente dipendente (anche emotivamente) dalla madre.
CONCLUSIONE
Come abbiamo visto, l’ipotesi migliore che spiega l’origine dell’omosessualità è quella psicologica.
Affermare che l’omosessualità deriva da dinamiche psicologiche, porta con sé delle implicazioni tutt’altro che irrilevanti.
Infatti comporta una ridimensione di questi comportamenti e stili di vita considerati “salutari” e “naturali” tanto quanto quelli eterosessuali e, per non parlare del fatto che tutte le rivendicazioni delle lobby LGBTQ+ sarebbero immediatamente smontate.
Ecco perché negli ultimi decenni la ricerca ha spesso tralasciato gli aspetti psicologici coinvolti nelle dinamiche alla base dell’omosessualità, perché se fossero state studiate, il castello di sabbia delle suddette lobby sarebbe caduto rovinosamente.
Ringraziamo gli amici di Instagram per il testo originale di @psico_attualitaa
Il blog di Luca